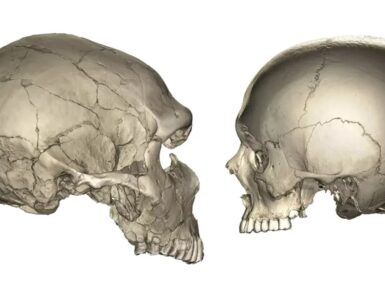Questa storia inizia in realtà qualche anno fa. Gli archeologi stavano scavando nel sito dell’ex Animal Husbandry Center presso il Nescot College di Ewell, nel Surrey, quando hanno fatto una scoperta sensazionale, anche se un po’ triste. Infatti hanno trovato i resti di un’antica cava romana, la quale presentava prove di offerte sacrificali e pratiche rituali risalenti al periodo romano. Ma la scoperta più importante fu quella relativa ai sacrifici di cani, una collezione di 5.436 ossa canine appartenenti ad almeno 140 cani.
Sacrifici di cani o una forma primitiva di eutanasia compassionevole?

Giustamente ci si è chiesti fino ad oggi il perché di quei sacrifici di cani. E finalmente, a dare forse una possibile risposta, ci ha pensato la dottoressa Ellen Green, paleopatologa dell’Università di Reading. In un articolo pubblicato sull’International Journal o Paleopathology, ha presentato alcune prove che hanno dimostrato come questi cani fossero sì stati sacrificati agli dei, ma solo dopo una lunga vita durante la quale erano stati ben accuditi dai loro proprietari.
Pare proprio che tali cani fossero animali domestici assai amati. Il che ha spinto a ipotizzare che il sacrificio sia avvenuto solamente quando i cani erano anziani, forse in un momento durante il quale i cani erano molto malati e fosse lecito per loro pensare a una forma di eutanasia compassionevole per evitare ulteriori agonie e sofferenze nelle fasi terminali delle loro vite. I cani, effettivamente, erano assai diffusi sia nella vita dei Romani che dei Britannici. Avevano sia ruoli pratici, visto che erano usati durante la caccia, per fare la guardia a case e bestiame e come cani da difesa, sia ruoli più domestici, come animali da affezione e compagnia.
In particolare, i cani britannici erano noti per la loro attitudine alla caccia. Tanto che, come sottolineato da Strabone, erano una delle esportazioni di maggior valore della Britannia.
Un altro aspetto da non sottovalutare, però, era l’importanza dei cani a livello simbolico e religioso nella cultura romana. Per esempio, Plutone, il dio degli Inferi, era spesso raffigurato insieme a un cane da guarda. Ed Ecate, la dea della magia e della luna, aveva dei segugi spettrali. Quindi probabilmente i Romani pensavano che i cani potessero essere delle guide o protettori durante la transizione fra la vita e la morte.
Ma torniamo agli scavi del pozzo rituale di Nescot. Il pozzo era di forma ovale ed era profondo circa 4 metri. La sua datazione lo colloca fra la fine del I e l’inizio del II secolo d.C. Originariamente era una cava romana, ma successivamente qualcuno riconvertì il sito in un deposito per resti animali, ossa umane, ceramiche, monete, oggetti di metallo e anche gettoni da gioco. Secondo gli archeologi, ci sono tre fasi ben distinte nell’uso del pozzo. Le prime due fasi sono quelle che contengono la maggior parte dei resti animali, soprattutto cani, mentre la terza fase è quella che vede il declino del sito come zona rituale visto che era usato maggiormente come discarica.

Considerate che nella maggior parte dei siti archeologici romano-britannici, i resti di cane non superano mai il 4% delle ossa animali trovate. Ma non a Nescot: qui, su 10.747 ossa recuperate, più del 50% appartenevano a cani. Lo studio della dottoressa Green ha permesso di ricavare diverse informazioni utili. La maggior parte dei cani apparteneva a razze di taglia piccola. Alcuni di essi presentavano segni di condrodisplasia, un disturbo genetico caratterizzato da arti più corti del normale. Un po’ come nei moderni Corgi, insomma. Inoltre sappiamo che i Romani avevano cani da compagnia di piccola taglia simili ai moderni Maltesi, il che guarda caso coincide con molti dei resti di Nescot.
Molti dei cani presentavano segni di cure a lungo termine collegati a malattie tipiche dell’età avanzata, come la spondilosi deformante, una malattia degenerativa a carico della colonna vertebrale e l’ossificazione delle cartilagini costali, fenomeno che si verifica durante l’invecchiamento del cane.
In generale tutti i cani mostravano i segni di una lunga vita e di cure. La contestuale presenza di resti umani suggerisce come i cani di Nescot fossero coinvolti in attività cerimoniali o sacrificali. Inoltre la dottoressa Green ha ipotizzato che la selezione degli animali a scopi rituali dipendesse anche da tradizioni culturali. Queste le sue parole: “I Romani avevano linee guida specifiche per quanto riguarda tipi, colori, età e sesso degli animali appropriati per il sacrificio a diverse divinità. È altamente plausibile che questi cani siano stati scelti in base a tali criteri rituali”.

Tuttavia, nel corso del tempo, il pozzo di Nescot cambiò la sua funzione. Il numero di animali diminuì sempre di più e quei pochi ritrovati riportano i segni tipici della macellazione. Dunque gli animali ritrovati durante la terza fase del pozzo non erano più usati a scopo rituale, bensì alimentare. All’inizio del II secolo d.C., poi, il pozzo fu abbandonato del tutto, forse a causa anche dei mutamenti delle usanze.
Rimangono però da chiarire alcuni dubbi. Se effettivamente i cani erano sacrificati alla fine delle loro vite, quando magari erano ormai malati e incurabili, a quale divinità romana erano consegnati i loro spiriti? E la presenza di ossa umane nel pozzo significa che a volte anche le persone erano sacrificate insieme a loro?