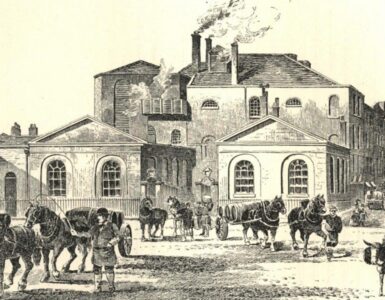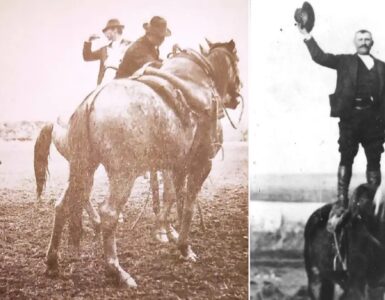Per Kempeitai (憲兵隊, “Corpo di soldati della legge”) intendiamo la polizia militare dell’Esercito imperiale giapponese, attiva dal 1881 al 1954. Spesso paragonata alla Gestapo nazionalsocialista per i metodi brutali adottati e il suo potere illimitato, la Kempeitai operò non solo come forza di polizia interna, ma anche come strumento di repressione nei territori occupati. Il suo ruolo fu centrale nel mantenere il controllo del regime militare giapponese, sia all’interno dell’Impero che nelle sue zone di espansione. La vicenda di questo corpo di polizia riflette un po’ la storia del paese del Sol Levante, della sua progressiva deriva autoritaria così come della sua mentalità imperialistica.

Una storia che, come anticipato nelle precedenti battute, inizia nei primi anni ’80 del XIX secolo, un momento fondativo del Giappone contemporaneo. Erano quelli gli anni della commissione adibita alla redazione di una costituzione, dell’ammodernamento tecnologico e industriale, il quale doveva procedere di pari passo con quello militare. Il motto wakon yōsai (和魂洋才, “conoscenza europea, spirito giapponese“) non esisteva a caso. La modernizzazione dell’esercito seguì due modelli in particolare: quello francese della Gendarmerie nationale e quello prussiano del Reichsheer.
In questo esatto contesto venne promulgato il decreto “Kempei Jourei” (giapponese: 憲兵条例); l’atto di nascita ufficiale della Kempeitai. Inizialmente, il suo compito era quello di garantire la disciplina tra i soldati e fungere da polizia militare, ma col tempo acquisì poteri sempre più ampi, fino a diventare un organismo di sorveglianza politica e repressione del dissenso. Altro compito degli albori fu quello di monitorare – e nel caso stroncare – i crescenti disordini dovuti alla coscrizione obbligatoria. Al termine del XIX secolo, a vent’anni circa dalla sua creazione, la Kempeitai contava poco meno di 400 uomini. Un numero che nel secolo successivo sarebbe aumentato esponenzialmente.

Con l’avvento del XX secolo, si moltiplicarono le funzioni del corpo di polizia militare. Ad esempio prese a svolgere mansioni per conto del Ministro della Guerra (anche nei territori occupati a partire dal 1910), così anche per altri due decasteri, quello della Giustizia (in veste di polizia giudiziaria) e dell’Interno (assistenza alla polizia civile).
Si deve alla Kempeitai l’assassinio dell’imperatrice coreana Myeongseong, la quale nel 1895 aveva chiesto aiuto ai russi per combattere l’invasione nipponica. In Corea il corpo di polizia militare si macchiò di svariate atrocità, arresti arbitrari, torture ed esecuzioni sommarie. L’esperienza nella penisola coreana fu per essa un banco di prova. Infatti le medesime brutalità resteranno una prerogativa anche negli altri territori occupati, come in Cina e nel Sud-est asiatico.

Nel 1911 la Kempeitai si dotò di un’unità segreta interna denominata Tokubetsu Koto Keisatsu (特別高等警察), abbreviata in Tokkō. Essa si occupò di monitorare sospetti dissidenti, comunisti e attivisti anti-governativi. In generale rappresentavano per il regime militare giapponese uno strumento da utilizzare contro le ideologie avverse all’ordine pubblico o alla sicurezza nazionale. Uno strumento estremamente efficace azzarderei a dire, vista l’impunità garantita dallo Stato e la piena libertà d’azione di cui godeva. Per arrestare qualcuno non serviva un mandato, ma una semplice segnalazione, anche anonima. Ma è con gli anni ’30 che la Kempeitai si evolve notevolmente, alla stregua del Giappone, che vive la sua “rivoluzione militare nazionalista“.
Sia la polizia militare che l’Esercito imperiale seguirono una dottrina nota come Kōdōha (皇道派, “Fazione del Cammino Imperiale”), impregnata di elementi ultra-nazionalisti, militaristi e totalitaristi. Secondo i seguaci della Kōdōha si poteva giungere ad una vera unità nazionale solo attraverso il potere delle armi (sottintesa era la subordinazione degli organi civili e persino dell’imperatore, la quale autorità era relegata ad un ambito sacrale, nonché cerimoniale).

L’invasione militare della Manciuria da parte del Giappone fu il primo atto della lunga guerra che il Sol Levante dovrà condurre. La Kempeitai che ruolo svolse in stato di guerra? Nei territori occupati sovrintese ai campi di prigionia per soldati e civili nemici, spesso ricorrendo alla cara buon vecchia tortura per estorcere informazioni più o meno valide. I prigionieri erano sottoposti a esperimenti medici e lavori forzati. I trattamenti inumani in aperta violazione delle convenzioni internazionali (che non rispettava quasi più nessuno) erano all’ordine del giorno. Un approfondimento in tal senso può essere quello sui crimini commessi dall’Unità 731 o su ciò che accadde a Nanchino nel 1937.

A proposito di 1937, è di quell’anno una stima che ci fa capire di che ordine di grandezza stiamo parlando. Nella Kempeitai dovevano essere inquadrati 315 ufficiali e oltre 6.000 uomini; negli anni ’40 il numero di ufficiali raddoppiò, mentre quello dei sottoposti aumentò ma di poco. Per i motivi fin qui citati, questo corpo di polizia specifico dell’Impero del Giappone si costruì una fama non dissimile da quella “guadagnata” altrove dalla Gestapo nazionalsocialista o dall’NKVD sovietico. Dopo la resa del Giappone nel 1945, gli Alleati sciolsero ufficialmente la Kempeitai. Molti dei suoi membri furono processati per crimini di guerra nei tribunali di Tokyo. Tanti altri riuscirono a sfuggire alla giustizia, talvolta protetti da ex colleghi o da potenze straniere che li impiegarono nella Guerra Fredda.