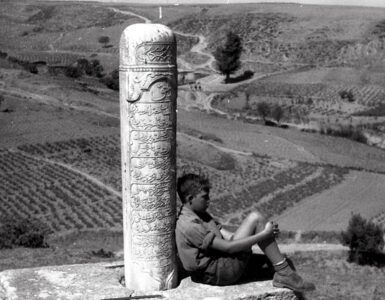A partire dall’epoca dei lumi (per diversi motivi potremmo riferirci anche al XVI secolo) varie correnti di pensiero e movimenti più o meno politicizzati hanno cercato di “denudare il cielo”. Cosa vuol dire? Parlando di religione cristiana sarà capitato di riferirsi a un cielo brulicante di santi, una sorta di Pantheon cristiano arricchitosi nel corso del tempo. Ma i santi non si trovavano solo in cielo! Restavano “vivi da morti” nei loro corpi, le quali parti, meglio note come reliquie venivano custodite in altari loro dedicati. Culto delle reliquie, per l’appunto.

Così accadeva che la mano di un santo morto in una città del centro Italia si trovasse in Francia e via discorrendo. Ebbene le reliquie si muovevano lungo le vie del pellegrinaggio, e sfruttavano una ricca rete di relazioni. Una volta arginata la questione della manomissione dei corpi nel tardo antico, le reliquie divennero doni, simboli del potere, sacrale e politico.
Durante i primi secoli la chiesa non aveva una voce unica e autoritaria, appariva piuttosto come una congregazione di comunità in cui nessuna appariva più rilevante dell’altra. Perciò mettere ordine in materia non fu semplice, iniziò a delinearsi il così detto mos latinorum a cui si contrapponeva il mos grecorum. Due usanze differenti. La prima seguendo le leggi romane rispettava l’integrità dei corpi, la seconda più diffusa nella parte orientale dell’impero, tendeva a “spezzettarli”.

La contrapposizione tra i due diversi mos, finì con l’assumere l’aspetto di una rivalità tra Roma e Costantinopoli. Furono due papi tra il V e il VI secolo d.C. a doversi assumere la responsabilità di farsi garanti dell’integrità dei corpi, ciò spinse a soluzioni di maggiore ingegno. Si diffusero anche i brandea, ovvero degli oggetti che venivano a contatto con il corpo del santo e che ne assorbivano la virtus.
Fioccarono nel tardo antico una serie di scritti tra cui un genere letterario noto come Traslationes che trattavano proprio dei percorsi miracolosi di questi pegni di santità. Si ricordi quella composta da Eginardo, cronista di Carlo Magno. Tramite il racconto del viaggio della legazione di cui faceva parte, direttasi a Roma per impadronirsi di una reliquia, si evincono due cose. La prima è il valore religioso e la seconda è il valore politico dell’oggetto del desiderio.

In breve tempo in Occidente e Oriente non esistette chiesa il cui altare non custodisse una reliquia, con gemme preziose che le adornavano e le conferivano sacralità.