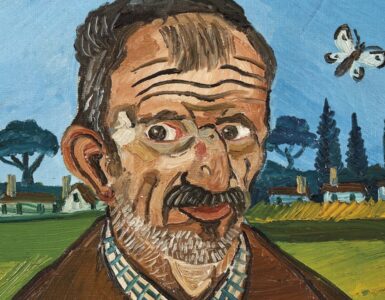In pieno XIX secolo ci si riferiva ad essa con vari nomi: prima come Veduta di architettura, in seguito come Prospettiva o Studio di prospettiva. Oggi invece siamo tornati a chiamare questa magistrale opera col suo nome originale, ossia – perdonatemi la rima – Città ideale. Ne esistono molteplici versioni, tutte ugualmente interessanti e curiose. Ve ne è una che il sottoscritto ha avuto il piacere e l’onore di ammirare a Berlino (attribuita con riserva ai pittori Francesco di Giorgio Martini e Pietro Orioli), nella Gemäldegalerie. Un’altra si trova a Baltimora, forse realizzata dall’urbinate Fra Carnevale, pseudonimo di Bartolomeo di Giovanni Corradini. Ma l’opera che più di ogni altra ha attirato l’attenzione di storici, critici d’arte, curiosi ed appassionati è attualmente esposta ad Urbino, per la precisione nella Galleria Nazionale delle Marche.

La Città ideale di Urbino non ha una datazione esatta. Si pensa sia stata realizzata tra il 1470 e il 1490. Se pensate che la forbice temporale possa sembrare troppo ampia e incerta, conservate le perplessità per dopo, perché il dipinto simbolo del Rinascimento italiano è un concentrato di enigmi, ambiguità e misteri. Ad esempio sfugge alla maggior parte degli studiosi il nome dell’autore. Qualcuno ha posto sul tavolo delle ipotesi alcuni dei principali artisti patrocinati da Federico da Montefeltro, capitano di ventura, prima conte, poi duca di Urbino dal 1444 al 1482. E allora scomodiamoli questi grandi nomi coccolati dalla signoria marchigiana: Piero della Francesca, i già citati Fra Carnevale e Francesco di Giorgio Martini, per non dimenticare gli eccelsi Donato Bramante e Luciano Laurana, quest’ultimo progettista del Palazzo Ducale di Urbino.
Nomi su nomi, ipotesi che si rincorrono, ma nulla più. In virtù di ciò, si tende a riconoscere l’anonimato per quanto riguarda il pennello dietro la Città ideale. Di proprietà dei Montefeltro fino al 1525, quando con la morte di Elisabetta, secondogenita del duca Federico rimasta vedova e dunque fattasi monaca, il dipinto divenne patrimonio del Monastero di Santa Chiara. Nel 1861 passò dal monastero al neonato Istituto di Belle Arti di Urbino, dal 1912 Galleria Nazionale delle Marche.

Perciò sono almeno 160 anni che i più abili tra i critici d’arte si interrogano sul senso intrinseco dell’opera. Quasi sicuramente l’intento originario fu quello di esaltare il criterio prospettico, influenzato dalle concezioni neoplatoniche in voga al tempo e dalle teorie urbanistiche utopiche, care al coevo Thomas More (Tommaso Moro se preferite), i posteriori Campanella, Bacon, Thomas Müntzer, i settecenteschi Étienne Cabet e Charles Fourier. Uomini dalla profonda cultura umanistica (o illuministica, negli ultimi due casi citati) che seppero tramutare gli ideali di armonia e conformità in capolavori letterari senza tempo, rappresentativi della mentalità dell’epoca.
Osservando la Città ideale – in ogni sua salsa, si tenga a mente – traspare vividamente ciò. Simmetrie e geometrie vengono ad intrecciarsi in un connubio prospettico esaltante. Guardate la pavimentazione, razionale per composizione e schematicità (anche se il termine inglese “pattern” rende meglio il concetto). Sembra quasi che ogni angolo, ogni scorcio dell’opera artistica risalti la prospettiva fiorentina. La stessa che maestri come Brunelleschi, Leon Battista Alberti e Piero della Francesca hanno contribuito ad affermare, aggiornare e perfezionare.

Nel dettaglio non si può ignorare la centralità dell’edificio religioso a pianta circolare. Due ordini di colonne si spartiscono piano inferiore e superiore. Nel primo sono chiaramente corinzie; nel secondo si distinguono come semicolonne. Il battistero (anche se qualcuno in tempi non sospetti l’ha definito mausoleo, ma la croce dorata sulla sommità lascia presupporre la prima opzione) domina una piazza larga e spaziosa. A sua volta essa è circondata da palazzi di pregevole fattura, in marmo policromo. A seguire, verso lo sfondo, si stagliano strutture meno appariscenti, popolari oserei dire ma comunque “asservite” all’ideale di città perfetta.

Tornando per un momento sui palazzi in primo piano, mi piacerebbe alimentare la succitata aurea di mistero conducendo la vostra attenzione sui rispettivi timpani. Se vi casca l’occhio, potete notare come vi siano due lapidi con iscrizioni. Ecco, sono un bel problema, perché a distanza di secoli nessuno, ma proprio nessuno, è riuscito a decifrare il loro messaggio. La profondità però non è un concetto asettico, ma trova piena espressione grazie alle colline che sulla sezione di destra appaiono soavi. Altresì la chiesa, sempre sulla destra, arricchisce un paesaggio urbano che sembra “morto” (dove per “morto” s’intende “assenza di vita”) ma che esanime non è. Le piante non sono mica vita? Le tortore appollaiate sul palazzo giallognolo non forniscono un senso di vitalità, seppur minimo e poco appariscente?

Per chiudere l’analisi mi avvalgo delle esaurienti parole di Luca Molinari, co-autore assieme a Luigi Gallo e Federica Rasenti di Città di Dio. Città degli Uomini. Architetture dantesche e utopie urbane. L’architetto interpreta così il significato della porta battisteriale, semiaperta e perciò conturbante se confrontata alla perfezione emanata dall’opera. Molinari scrive: “Quella linea d’ombra al centro dell’asse prospettico ha il potere di slittare il nostro sguardo e le certezze rispetto alla potenza del mezzo prospettico, perché il centro della composizione si situa in un terreno incerto, di passaggio, tra luce e buio. Una soglia che invita a entrare e che, insieme, stabilisce il limite tra la città degli uomini e quella di Dio. In quello spessore sottile possiamo immaginare il confine ideale tra il mondo terreno e quello del sacro, tra l’ideale e il materiale…”.