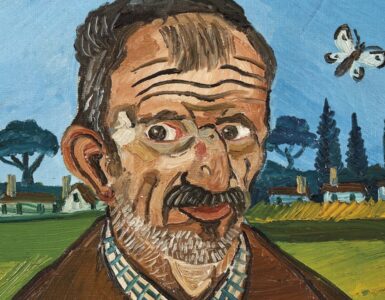Tra il 1880 e il 1886 Arnold Böcklin consegna ai posteri cinque dipinti rappresentanti lo stesso soggetto. Il quintetto di tele concorre alla storia con il seguente nome “L’isola dei morti“. Inizialmente l’idea è quella di un dipinto su commissione e la mano che offre il denaro è del ricco mecenate tedesco Alexander Günther. Realizzata l’opera, l’artista finisce per innamorarsene e la custodisce per sé, rinunciando ai soldi promessi. Sentirsi stregati da quel simbolismo magnetico sarà un leit motiv per molti altri a venire, uomini che segneranno il corso della Storia e che, in alcune occasioni, lo faranno in stanze ospitanti lo stesso quadro (ogni riferimento all’uomo baffuto nato in Austria ma cresciuto politicamente in Germania, cancelliere e capo di stato nazionalsocialista dal 1933 al 1945 del quale non possiamo dire il nome altrimenti cesseremo di esistere a causa del perbenismo altrui è puramente casuale – da leggere tutto d’un fiato).

Il quadro, che entro i stretti confini del circolo artistico iniziò a farsi un nome, piacque così tanto a Marie Berna contessa di Oriola che ella, con sonante denaro, ne commissionò altre quattro versioni oltre all’originale. Die Toteninsel (nome in tedesco dell’opera) divenne nel giro di pochi anni fonte d’ispirazione per innumerevoli artisti, attratti dall’innovazione simbolica proposta e volenterosi di divulgarla, talvolta modificando l’originale a proprio piacimento. L’enigmaticità – che tra poco analizzeremo nel dettaglio – sequestrò la fantasia di intellettuali e filosofi, poeti e compositori, politici e uomini di stato. Solo per citarne alcuni: Lenin, il baffetto tedesco amante della razza ariana, D’Annunzio, Sigmund Freud, Sergej Rachmaninov, ma la lista potrebbe continuare a lungo.
Nel 1888 Arnold Böcklin dipinge Die Lebensinsel (L’isola dei vivi), contraltare concettuale all’oscuro e magnetico (quasi) omonimo. La tela vuole lanciare un messaggio positivo, carico di speranza e amore per il prossimo. Il sole, le danze, la luce così fulgida da far sembrare paradisiaca la flora naturale. Tali elementi rappresentano un knock out nei confronti dell’enigmatico oblio de “L’isola dei morti“. Eppure questa gioia vitale serve a me (come serve allo spettatore) per iniziare a presentare per contrasto quella tela che in molti, chissà con quanta allegria, hanno definito “la notte della vita”. L’analisi verte sulla prima versione anche se gran parte delle considerazioni concettuali sono valide per le successive redazioni.

Mi sembra corretto partire dal soggetto della composizione artistica, l’isola. L’altura rocciosa è disegnata per non essere vergine del tocco umano, infatti con neppure troppo sforzo si intravedono colonne templari, leoni di pietra scolpiti, sepolcri custodi di un’antichità perduta tra le sabbie del tempo. L’organico non si presenterebbe neppure così tetro se non fosse per i colori spenti e sfumati, riconducibili al silenzio luttuoso, a sua volta richiamato da un folto assembramento di cipressi. Immobile ed immutabile è l’acqua, la quale in maniera innaturale aggiunge angoscia alla lista dei sentimenti di chi osserva – forse impaurito, forse estasiato – la tela. Su quella lastra liquida muove un legno, una piccola imbarcazione placida nell’andamento. Facile, troppo anche, riconoscervi un Caronte ed un’anima, coppia di viaggio verso l’inesorabile.

Dare un significato univoco all’isola, alle due figure antropiche, all’acqua, ai cipressi e così via, non è possibile. Non lo è perché nella testa di Böcklin questa possibilità non è mai esistita. L’autore voleva evocare sensazioni differenti a seconda della concezione che ognuno dei spettatori aveva sulla vita e sulla morte.

Fortunatamente non siamo automi e possiamo pensarla in modi differenti su un qualcosa che, prima o poi, ci coglie tutti all’unanimità, almeno nella carne. L’arte in ogni sua espressione, in fondo, è eternatrice e sfugge da questi ragionamenti poco teorici e molto pratici. Arnold Böcklin lo sapeva benissimo e con “L’isola dei morti” ne diede prova, non una, bensì cinque volte.