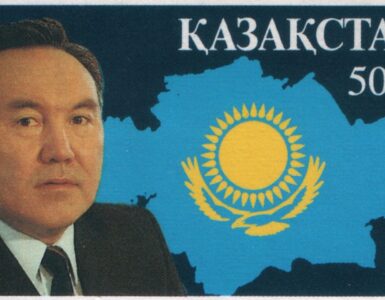Almanacco del 23 aprile, anno 181 a.C.: secondo fonti primarie (Tito Livio, Ab Urbe condita – Ovidio, Fasti), il duumviro romano, già console nel 184 a.C., Lucio Porcio Licino fa erigere il maestoso Tempio di Venere Erycina sul Quirinale. Il magistrato abbellì Roma con un secondo edificio di culto dedicato alla dea dell’amore, dopo quello voluto nel 215 a.C. dal dittatore Quinto Fabio Massimo Verrucoso.

Il culto di Venere Erycina era uno dei numerosi praticati dai Romani per la dea Venere, in quanto protettrice della fertilità, perciò come Dea Natura, nota in ambiente ellenico come Afrodite Erycina. Stando alle parole di Tucidide, poi riprese e aggiornate da Virgilio e Diodoro Siculo, Erice (Eryx) fu fondata da esuli troiani in Sicilia solamente dopo essersi uniti alla popolazione autoctona. Dall’incrocio di queste genti mediterranee nacque il popolo degli Elimi. Tucidide semplificò molto tuttavia il vero processo alla base della fondazione di Eryx, nella Sicilia occidentale.
Ai fini della nostra narrazione, incentrata sulla fondazione del Tempio di Venere Erycina sul Quirinale il 23 aprile 181 a.C. è importante sottolineare la seguente cosa: secondo le evidenze archeologiche, gli Elimi, di origine anatolica-hittita, veneravano una divinità femminile della fecondità ben prima che entrassero in contatto con i Greci. Si dice già dall’VIII secolo a.C. Un culto che sopravvisse in loco alla contesa territoriale tra Siracusani e Cartaginesi, nonché all’avvento del dominio di Roma, datato 244 a.C.

Sappiamo con relativa certezza come gli Elimi venerassero la dea con il nome di Astarte, i Cartaginesi con il nome di Tanit e i Pelasgi come Afrodite. I Romani riedificarono ad Eryx un tempio dedicato a Venere, incorporando tutte le pratiche cultuali preesistenti e adattandole alle proprie consuetudini religiose. Fu solo questione di tempo prima che il culto di Venere Erycina venisse esportato nel cuore della Res Publica.
Il primo tempio, come precedentemente anticipato, fu votato dal dictator Quinto Fabio Massimo Verrucoso nel 217 a.C. (dopo l’eclatante sconfitta patita sul Trasimeno) e dedicato nel 215 a.C. Differente fu la genesi del secondo tempio, sorto nei pressi di Porta Collina, sul colle del Quirinale. Lo votò nel 184 a.C. l’allora console Lucio Porcio Licino durante la guerra con i Liguri, mentre la dedica avvenne il 23 aprile 181 a.C.
Piccola digressione di carattere etimologico: “votare” e “dedicare” un tempio sono due atti differenti ma connessi. Votare (votum) significa promettere solennemente la costruzione di un luogo sacro in cambio di qualcosa, gentilmente concesso dal dio al quale ci si riferisce. Dedicare (dedicatio), invece significa erigere l’edificio e consacrarlo alla divinità. Questa sequenza seguiva la logica del do ut des (do affinché tu dia), tipico della religiosità romana.

Tornando a noi, il 23 aprile assunse una valenza simbolica e religiosa importante per il mondo romano. In quella data, a partire dal 181 a.C., le prostitute festeggiarono la loro festa, nota come dies meretricum. Il perché è presto detto. All’interno del Tempio di Venere Erycina si praticò a lungo il rituale della prostituzione sacra. Ogni 23 aprile le prostitute si recavano nel tempio in processione, portando corone di rose e mirto, piante sacre a Venere. Le donne chiedevano alla divinità di poter preservare la bellezza nonché la loro salute; ovviamente affluivano per l’occasione una folta schiera di uomini, pronti a cimentarsi in contrattazioni di carattere sessuale.
Il tempio originale di Eryx, in Sicilia, rimase intatto fino al I secolo a.C. Subito dopo decadde con l’involuzione economica dell’isola, non più al centro di un grande stato repubblicano in procinto di diventare impero. Per quanto riguarda il tempio situato sul Quirinale, a detta di studiosi e archeologi, gli Horti Sallustiani del I secolo a.C. inglobarono lentamente il luogo di culto. In virtù di ciò, i Romani presero a chiamare il tempio Aedes Veneris Hortorum Sallustianorum. Di quel santuario oggi non resta molto.

Tra i reperti più affascinanti citiamo il cosiddetto Trono Ludovisi e l’Acrolito Ludovisi. Il primo altro non è che un trittico in marmo tasio di produzione locrese, databile al 450 a.C. Il secondo manufatto è una colossale testa femminile in marmo, forse proveniente dalla Magna Grecia o dalla Sicilia (dal primo tempio di Erice). Entrambi i reperti sono esposti al pubblico nelle sale del Museo Nazionale Romano.