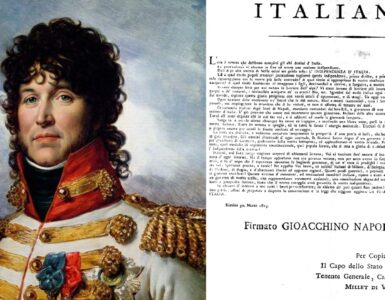Almanacco del 2 aprile, anno 2002: ha luogo il cosiddetto “assedio alla basilica della Natività” a Betlemme. Il contesto è quello della Seconda intifada (2000-2005). L’episodio in questione, uno dei più drammatici della rivolta palestinese, si protrasse per 39 giorni esatti. Coinvolse le Forze di Difesa Israeliane (IDF) e alcuni militanti palestinesi ricercati, inquadrati nelle organizzazioni di Ḥamās, al-Fatḥ, dello Jihad Islamico in Palestina e del FPLP (Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina). Circa 220 uomini si asserragliarono all’interno del santuario, uno dei luoghi più sacri per il cristianesimo. Ciò suscitò forte indignazione internazionale, sia per lo sfruttamento di un luogo sacro come rifugio militare, sia per il prolungato assedio che mise a rischio vite civili e patrimonio storico.

Come risaputo, nel settembre 2000 scoppiò la Seconda intifada. Una nuova ondata di violenze tra palestinesi e israeliani, innescata dalla visita di Ariel Sharon, capo del partito Likud, alla Spianata delle Moschee – Monte del Tempio, a Gerusalemme. Secondo la versione palestinese, la visita fu appositamente provocatoria. Secondo il punto di vista israeliano, il gesto di Sharon funse da pretesto per i palestinesi, pronti a dar vita ad un’insurrezione attentamente pianificata. Nei due anni successivi, il conflitto si intensificò, con attacchi suicidi palestinesi da una parte e offensive militari israeliane dall’altra.
Il 27 marzo 2002 un attentato al Park Hotel di Netanya, poi rivendicato da Ḥamās, comportò la morte di 30 israeliani e il ferimento di altre 140 persone. Due giorni dopo Israele lanciò un’operazione militare su larga scala nei territori della Cisgiordania: l’Operazione Scudo difensivo. Betlemme, città sotto il controllo dell’autorità palestinese, fu uno degli obiettivi prestabiliti dall’offensiva.

Le truppe israeliane entrarono nella città il 2 aprile, incontrando una scarsa e disorganizzata resistenza. I principali esponenti del governo locale, più altri militanti palestinesi, decisero di chiudersi all’interno della basilica della Natività. Immediatamente si fece esplicita agli attori in gioco la natura complessa dello stallo. L’allora portavoce dell’IDF, il generale di brigata Ron Kitri, ammise di non voler utilizzare armi letali in un luogo di culto come quello ma che, al contempo, avrebbe circondato la basilica fino alla stretta di un accordo valido. Il patriarca latino di Gerusalemme, massima autorità cattolica nella regione, affermò di aver deliberatamente concesso il rifugio ai miliziani, purché abbandonassero le armi.

La comunità internazionale mantenne fisso lo sguardo sull’assedio alla basilica della Natività di Betlemme, iniziato il 2 aprile 2002. Buona parte dell’Occidente palesò preoccupazioni sul modus operandi israeliano, considerato sproporzionato e talvolta “totalmente inaccettabile” (cit. Ben Bradshaw, del Foreign Office britannico). Lo stesso Vaticano fece pressioni per un immediata de-escalation. La tensione però aumentò e il 16 aprile, a due settimane esatte dall’inizio dell’accerchiamento, ci fu uno scontro a fuoco nel perimetro della chiesa. Due uomini finirono in ospedale, mentre un sedicenne palestinese uscì dall’edificio e si consegnò all’IDF.

Dopo settimane di stallo, Stati Uniti d’America, Europa e Vaticano mediarono un accordo tra le parti. Il 9 maggio si arrivò alla seguente intesa: 26 militanti avrebbero intrapreso la strada per Gaza; 85 civili sarebbero stati rilasciati previa perquisizione israeliana; i 13 funzionari dell’autorità palestinese sarebbero rimasti all’interno della chiesa, supervisionati da un commissario delegato dall’Unione Europea, e in seguito trasferiti in Spagna e Italia. Gli ultimi 13 uomini uscirono allo scoperto il 10 maggio, evitando però i giornalisti. Finì così, con la diplomazia, l’ennesimo capitolo di un conflitto, come quello israelo-palestinese, per sua apparente natura irrisolvibile. L’attuale cronaca ce lo ricorda drammaticamente.