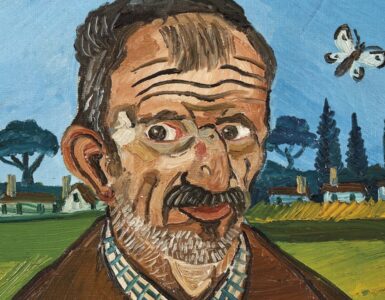In una storia dell’arte scritta tutta al maschile, Artemisia Gentileschi rappresenta una delle pochissime figure femminili inserite nella manualistica corrente. Donna coraggiosa e indipendente, attentissima ai contemporanei sviluppi del Barocco e non solo, la pittrice crebbe a Roma nei primi anni del Seicento. Nella Roma che aveva ospitato Caravaggio, tanto osteggiato quanto ammirato dopo l’inaugurazione del ciclo di San Matteo nella Chiesa di San Luigi dei Francesi (1600), l’interesse di Artemisia per l’arte nacque subito, fra le mura domestiche.

Infatti il padre, Orazio, era già pittore. Sul volgere del nuovo secolo aveva conosciuto direttamente il Merisi, destinato a diventare una presenza di rilievo nella vita tanto privata quanto professionale di Gentileschi. Intorno al 1608-10, infatti, gli inizi pienamente tardomanieristi del padre di Artemisia si presentavano già sfumati. L’intenso chiaroscuro, il senso drammatico del reale e l’uso della scenografia – tutti elementi caravaggeschi – erano stati già assorbiti da Orazio quando la figlia, adolescente, intraprese la propria carriera artistica.
Ne è una prova il dipinto “Giuditta e l’ancella con la testa di Oloferne”, che Orazio terminò nel 1608 proprio con l’aiuto di Artemisia. Il soggetto del quadro, che la pittrice avrebbe trattato in altre forme circa dieci anni dopo, è biblico. Secondo il testo sacro, la giovane ebrea di Betulia liberò Israele dall’assedio dell’esercito guidato da Nabucodonosor, e lo fece decapitando con l’inganno il generale assiro Oloferne. Infatti la donna, fingendo di volersi alleare, si era recata nell’accampamento nemico, dove il soldato straniero era rimasto incantato dal suo fascino. Così, approfittando del sonno di Oloferne, Giuditta gli aveva reciso il capo.

A quelle date, in realtà, la storia di Giuditta e Oloferne era un soggetto piuttosto diffuso negli ambienti romani. Basti pensare che nel 2021 un’intera mostra di Palazzo Barberini ha delineato le tappe della scuola caravaggesca nella codifica del tema biblico. Eppure, nonostante Giuditta e Oloferne compaiano nelle tele di Caravaggio, De Boulogne, Mendozzi, Finson e Vermiglio, la versione di Artemisia degli anni ’20 si configura come una personalissima rielaborazione del soggetto.
Per parlare della versione della “Giuditta e Oloferne” della pittrice conviene fare un passo indietro. Già all’epoca era un fatto noto che nel 1611 Artemisia Gentileschi avesse subito violenza da parte di un pittore assistente del padre, Agostino Tassi. La questione, confluita nelle aule processuali, portò alla luce il coraggio della donna, che di fronte alle torture e all’ombra del “disonore” affermò sempre con tenacia la veridicità delle proprie accuse. Purtroppo Tassi, che aveva conoscenze di rilievo a Roma, rimase pressoché impunito. Tuttavia Artemisia non smise mai di reclamare l’esigenza di essere ascoltata, neppure in ambito professionale, dove rivendicò sempre i propri diritti di artista.

“Vi mostrerò, mio caro signore, cosa può fare una donna“: lo avrebbe detto, anni dopo, a un committente piuttosto avaro. Artemisia avrebbe dimostrato bene cosa può fare una donna, che si tratti dell’eroina biblica o di se stessa. Non è un caso che qualcuno abbia voluto vedere nella sua versione del tema la proiezione autobiografica di una donna che si afferma di fronte alla dominazione maschile. Nessun dettaglio del gesto è risparmiato al lettore. L’eroina ebrea, infatti, muove con decisione la spada per recidere di netto la testa dell’uomo. Questa già sanguina in ogni direzione, mentre Giuditta la afferra per i capelli. La crudezza naturalistica dell’immagine, unita alla mano femminile che l’aveva plasmata, avrebbe fatto storcere il naso al committente. Intanto, però, Artemisia Gentileschi era diventata non solo la prima artista donna iscritta all’Accademia di Firenze, ma anche una pittrice ricercatissima nelle corti di Roma, Napoli e persino Londra.