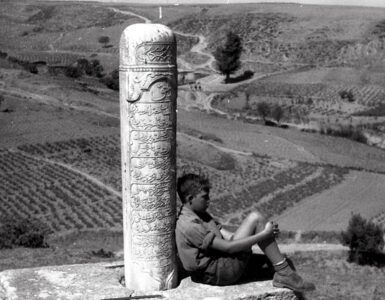Fare fiasco, quante volte le vostre orecchie hanno udito l’unione di questi due termini? Tutti sappiamo cosa significa, ma in pochissimi metterebbero la mano sul fuoco nell’individuare un’origine chiara e documentata della frase fatta. Esattamente in questa falla mi inserisco io, cercando di accorpare tutte (e due…) le supposizioni nate nel tempo sull’origine della particolare espressione idiomatica. Da dove iniziamo?

Qualcuno che “fa fiasco” solitamente fallisce in un’impresa, riporta un insuccesso plateale, uno smacco degno di nota. Si è soliti pensare in alcune parti di Italia che il modo di dire “fare fiasco” nasca dal mestiere del soffiatore di vetro. Faceva fiasco l’artigiano che produceva per sbaglio un recipiente simile a quello finora citato, al posto di un oggetto dalla forma più complessa ed articolata. In tal senso la frase fatta si associa alla sensazione di fallimento.
L’ipotesi che tuttavia sollecita maggiormente la curiosità delle persone – compresa quella del sottoscritto – ha a che fare con Domenico Biancolelli (1636-1688), in arte Domenique. L’attore teatrale nato a Bologna ma affermatosi artisticamente alla corte di Luigi XIV di Francia era solito vantarsi delle sue innate abilità recitative. Quello che da molti viene definito “l’unico vero Arlecchino” si esibiva spesso in degli spettacoli totalmente improvvisati, scegliendo come fulcro della sua narrazione persone o oggetti casuali. Sembra che una sera optò per un fiasco di vino ma la performance non piacque al pubblico. E così “fare fiasco” divenne un modo per indicare il più rovinoso degli insuccessi.

Ora, queste due ipotesi sono passate frequentemente al vaglio dei più rinomati lessicologi e in più di un’occasione sono state riscontrate delle anomalie. Secondo gli esperti l’origine per così dire “teatrale” dell’espressione appare più come una trovata aneddotica. Sarebbe la presenza del verbo “fare” a tradire l’ipotesi di Biancolelli, poiché non avrebbe senso presentare il fallimento dell’attore con un verbo all’infinito succeduto dalla parola fiasco. Lo so, sembra forzato, ma questo capriccio ha fatto accendere la spia degli specialisti della lingua interessati alla questione. Essi infatti hanno supposto un’origine ancor più radicata nel tempo rispetto alla metà del XVII secolo.

La prima spiegazione riportata, quella dei soffiatori di vetro, s’intende, sembra piacere maggiormente ai lessicologi. Il verbo fare in siffatto contesto troverebbe piena coerenza. Tuttavia l’ipotesi non è esente da criticità, anche se queste sono molto più sottili rispetto a quelle dell’espediente teatrale (si discute sul perché non ci sia l’articolo tra i due termini grammaticali; cosa possa indicare, ecc.).

Che sia la versione teatrale o quella vetraia, bisogna ricordare una cosa che a noi può apparire come banale ma chi s’interessa dello studio approfondito della lingua ritiene essere il principio fondante della metodologia. Gli aneddoti che pretendono di spiegare l’origine delle frasi presentano, disgraziatamente, la lingua come un qualcosa che si evolve nel tempo grazie al puro caso. O meglio, grazie all’accadere di determinati eventi che influenzano la “costruzione di un lessico”. Che detta così sembra una bestemmia, ma seguite il mio ragionamento: se quella sfortunata sera l’Arlecchino Biancolelli avesse usato un sedia invece di un fiasco, oggi staremmo dicendo “fare sedia” per indicare un fallimento. Ma non è così che funziona… Il più delle volte almeno (il caso della “quinta colonna” è l’eccezione che conferma la regola).
La lingua, nella sua forma scritta e ancor più velocemente nella forma parlata, si serve di infinite analogie, lessemi (singole unità linguistiche aventi significato autonomo) di ogni tipo, prestiti linguistici e via discorrendo per trasformarsi, progredire contemporaneamente alla realtà a cui si riferisce. Spesso chi osserva da lontano e cerca un senso a parole che apparentemente una logica tutta loro non ce l’hanno si serve degli aneddoti per facilitare la comprensione. Non che sia un reato, ma spesso la via più semplice non è quella che conduce alla meta desiderata.