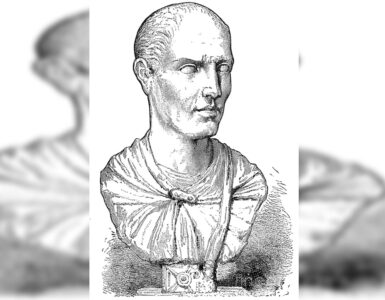Spesso ci siamo soffermati sulla vivacità e la complessità della vita sociale romana. Meno frequentemente abbiamo analizzato uno dei suoi aspetti più controversi, anche se non per questo desueti o singolari: quello della mercificazione sessuale del corpo. La prostituzione era una realtà quotidiana nell’antica Roma e nelle sue vastissime propaggini territoriali. Non solo era tangibile, ma anche legale se certificata e “localmente” riconoscibile per via del Lupanare (dal latino lupa=prostituta). Un semplice bordello a prima vista, luogo deputato al soddisfacimento del piacere sessuale nella sua veste mercenaria. Tuttavia gli studi condotti in merito da una lunga sequela di storici, archeologi specialisti e sociologi lasciano intendere ci sia qualcosa di più complesso ed articolato. Sì, perché lo studio del fenomeno fin qui approssimativamente introdotto offre un’interessante prospettiva sugli atteggiamenti romani nei confronti della sessualità, del classismo e del potere.

Ma se si vuole comprendere a pieno il fenomeno, lo si deve analizzare partendo dalla sua base materiale, visibile ed identificabile. Anzitutto è necessario ribadire come il Lupanare non fosse un luogo oscurato da una sorta di tabù, dunque celato da sguardi indiscreti. Al contrario il velo della clandestinità è una nostra prefabbricazione mentale. Queste case di tolleranza (per utilizzare un termine anacronistico ma calzante) erano strutture strategicamente situate nei vivaci centri urbani. Riconoscibili anche per via di un’inconfondibile segnaletica (falli a mo’ di cartelli…), i Lupanari erano frequentati da persone di ogni estrazione sociale. Marziale stesso giunse a definirli “aperti a tutti i venti” proprio a rimarcarne l’accessibilità universale. Se non credete all’indicazione letteraria, potete recarvi a Pompei ed osservare con i vostri stessi occhi l’appariscenza delle strutture in questione.

Sotto il punto di vista legale, c’è da dire come già in età tardo repubblicana esistesse una normativa atta a regolarizzare il funzionamento dei bordelli. I proprietari di quest’ultimi, detti lenones, erano tenuti a registrare i locali presso l’autorità e a rispettare delle norme standard riguardo l’igiene, la retribuzione e il pagamento delle tasse. Tutto ciò che avveniva all’interno dei Lupanari si svolgeva entro la cornice di un quadro giuridico ben delineato, capace di fornire “protezione” tanto ai lavoratori (uomini e donne) quanto ai clienti (esclusivamente uomini).

Come si è detto in precedenza, la clientela delle case chiuse (che tanto chiuse non erano…) era estremamente diversificata, riflesso della natura cosmopolita della società romana. Se la domanda era variegata, anche l’offerta non era da meno. Non tutti gli stabili erano uguali: ve ne erano alcuni più popolari, altri altamente facoltosi. Ma l’aspetto che accomunava tutti i Lupanari era la complessità caratterizzante il loro ecosistema interno. Le prostitute – note come meretrices (verbo merere, guadagnare), ambulatrices (passeggiatrici), fornicatrices (quelle che esercitavano sotto i fornices, ossia i ponti), noctilucae (lucciole) – sottostavano ad una gerarchia da loro costituita. Esisteva un vertice, con figure altamente qualificate e dal rinomato prestigio, così come esistevano i piani inferiori di questa piramide.
Chi vi lavorava proveniva da contesti genericamente diversi. Si incontravano schiave, liberte, ma anche professioniste indipendenti. Sia chiaro, questa non è, nel modo più assoluto, apologia alla prostituzione. Suddette donne non sfuggivano all’etichettatura e allo stigma sociale che ne deriva. Inoltre non dimentichiamo la conclamata disparità di genere insita nella società romana. Maltrattamenti, soprusi, impunità, tutto ciò era parte di un gioco che noi, con l’occhio di chi vive nel XXI secolo, possiamo giudicare scorretto o illecito, ma che allora non era visto come un atteggiamento dissonante.

Un Lupanare si presentava al suo interno come una struttura dotata di un’area d’accoglienza (stando all’inestimabile modello pompeiano) e di stanze in cui poter consumare. Quest’ultime, discrete ed essenziali nella forma, erano decorate con affreschi dal carattere erotico. L’utilità degli adornamenti non era esclusivamente estetica, ma anche didascalica (facile immaginare in che modo). I bordelli svolgevano un’ampia gamma di compiti d’aggregamento sociale: non di rado servivano da scenari per spettacoli teatrali popolari. Ancor più spesso erano centri di musica e convivialità.
Frequentemente anche la modalità d’accesso al Lupanare seguiva una logica per noi impensabile. Durante i vari ludi, gli organizzatori lanciavano tra la folla i cosiddetti “lasciva nomismata”, che possiamo tradurre con “gettoni lascivi”. La loro funzione era molto semplice. Chi li possedeva, aveva diritto ad un giro gratis all’interno dei bordelli. È sempre il caro buon vecchio Marziale (autore che vive dal 38 al 104 d.C.) a riportare queste chicche.
Altri autori invece diedero sfogo ad una condanna morale del fenomeno, inteso come manifestazione del decadimento sociale romano. Tra questi annovero Seneca e Catone il Censore. Medesimo era l’appunto delle autorità religiose, le quali mal vedevano il costume e per questo tramutarono il preesistente culto di Lupa (di matrice pre-romana, fortemente influenzato dalla ierogamia) nelle più accettabili Lupercalia, feste incentrate sulla fertilità e la protezione del bestiame, dedicate al dio Luperco.

È tuttavia innegabile che i bordelli nell’antica Roma occupassero un ruolo complesso e sfaccettato all’interno della società, fungendo sia da luoghi di commercio sessuale che da spazi di espressione culturale. Sicuramente queste istituzioni riflettevano la diversità e le contraddizioni inerenti alla vita romana. Certamente il Lupanare non sfuggì alla sanzione morale e legale, eppure prosperò come centro vitale della vita urbana, in cui manifestare il duraturo fascino umano per il piacere e l’intimità.